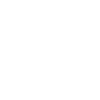- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
Il Monte Valerio e il sentiero naturalistico
Il Monte Valerio prende il nome da una ricca famiglia d’origine veneta di produttori di cioccolata che a metà Ottocento abitava nella villa in stile neo-medievale oggi oggetto di restauri. L’antico nome del colle - Metlica - è un fitonimo sloveno che fa riferimento all’artemisia, pianta aromatica un tempo abbondante, utilizzata in infusioni alcoliche.
Parte integrante dell'Orto Botanico Universitario, ma al di fuori del suo recinto e senza limiti d'orario, è il Sentiero Naturalistico del Monte Valerio, con diversi punti d'interesse valorizzati da cartelli esplicativi sulla flora e la fauna. Le stazioni del sentiero sono: il sito della Pervinca, il sito del Muschio, il sito del Bosco, il sito del Picchio, il sito del Lichene, il sito del Flysch, il sito del Pino e la cima. L'ingresso del sentiero si trova di fronte all'ingresso dell'Orto Botanico su via Licio Giorgieri, nei pressi del Castelletto.
Il primo tratto del sentiero naturalistico è caratterizzato da un elevato ombreggiamento dovuto ai numerosi esemplari di alloro (Laurus nobilis), tasso (Taxus baccata) residui dell’antico giardino che delimitava la villa. Poco più in alto si raggiunge la prima cenosi dominata dalla carpinella (Carpinus orientalis) con il sottobosco punteggiato da pungitopo (Ruscus aculeatus) e asparago selvatico (Asparagus acutifolius). Questi pendii scoscesi sono oggetto di intenso ruscellamento nei giorni di forti precipitazioni che causa l’ asporto degli strati più superficiali del terreno.

In ordine: Asparagus acutifolius, Taxus baccata, Laurus nobilis, Ruscus aculeatus in fiore e nel sottobosco con Carpinus orientalis. Foto di Andrea Moro CC BY-SA 4.0
Dove i pendii sono meno acclivi s’incontra il bosco di rovere, il Seslerio-Quercetum petraeae, un caratteristico bosco-prato dominato da una graminacea, Sesleria autumnalis che conferisce all’ambiente l’aspetto di un prato falciabile. Questa cenosi presenta uno strato arboreo composto da rovere (Quercus petraea), roverella (Quercus pubescens) che prevale sensibilmente nella parte più alta del colle e la carpinella (Carpinus orientalis). Lo strato arbustivo comprende corniolo (Cornus mas), sanguinella (Cornus sanguinea L. subsp. hungarica), ligustro (Ligustrum vulgare), quello erbaceo, oltre la sesleria, conta diverse specie tra cui l’erba amara dei boschi (Tanacetum corymbosum), ginestra spinosa (Genista germanica), ginestra minore (G. tinctoria), ginestra tubercolosa (G. pilosa) e la cicerchia nera (Lathyrus niger). La rovere, pur trovandosi nell’optimum climatico, raggiunge qui una taglia modesta (dai 15 ai 25 metri) spesso con ramificazioni a pochi metri dal suolo. Rispetto ai boschi del Carso nel monte Valerio c’è una vistosa diminuzione del carpino nero (Ostrya carpinifolia), dell'acero trilobo (Acer monspessulanum), del ciliegio canino (Prunus mahaleb), mentre si fanno più frequenti l'acero campestre (Acer campestre) e l'olmo minore (Ulmus minor).
Tra i muschi si possono osservare Tortula inermis, Tortella tortuosa e Bryum argenteum. Tra i licheni fogliosi sono facilmente riconoscibili Flavoparmelia caperata e Parmelina tiliacea.

In senso orario, dall’alto: Quercus petraea nel bosco-prato dominato da Sesleria autumnalis (foto centrale), frutto di Cornus mas, infiorescenza di Cornus sanguinea subsp. hungarica, ramo di Carpinus orientalis, ghianda di rovere. Foto di Andrea Moro CC BY-SA 4.0

In ordine: Ligustrum vulgare, Luzula multiflora, il lichene Flavoparmelia caperata, Lathyrus niger, Acer campestre. Foto di Andrea Moro CC BY-SA 4.0
I suoli sono terre brune decalcificate ed acide almeno in superficie, profonde oltre 50 cm, con forte capacità di trattenere l'acqua. La presenza dell’erba lucciola multiflora (Luzula multiflora), dell’erba lucciola mediterranea (Luzula forsteri) e della cannella dei boschi (Calamagrostis arundinacea) è sintomo di una certa diminuzione delle basi e quindi di una leggera acidificazione del suolo.
Il seslerio-querceto è la tipica associazione che interessa i terreni arenaceo-marnosi posti ai piedi del tavolato carsico in una stretta fascia delimitata dal mare, dalla città di Trieste e dal gradino carsico. Nei secoli passati questi pendii erano dominati da culture quali la vigna e l’ulivo con lembi di bosco limitati agli scoscesi versanti esposti a nord sfavorevoli all’agricoltura. Questi frammenti di bosco - la più comoda fonte di legname per la popolazione locale - venivano solitamente tenuti a ceduo per legna da ardere. Con l'abbandono delle attività agricole ed il conseguente cessare dei fattori di disturbo, il bosco ha rapidamente riguadagnato terreno.
Dove il manto forestale si fa meno denso, il sentiero consente di ammirare una sorprendente associazione vegetale – unica in Friuli Venezia Giulia - connubio tra specie nord atlantiche e mediterranee. Le brughiere a Calluna vulgaris e Genista germanica, tipiche dell’Europa occidentale a clima oceanico, si compenetrano con il mediterraneo cisto femmina (Cistus salviifolius). Il ‘matrimonio’ nasce dal contatto tra il limite settentrionale della distribuzione del cisto con l’areale prettamente europeo occidentale del brugo. Sia la brughiera che la cistaia sono favorite dagli incendi, a loro volta legati alla pastorizia. Questa convivenza anomala favorita dalle attività è ora minacciata dal ritorno del bosco.

Cistus salviifolius, Calluna vulgaris e Genista germanica. Foto di Andrea Moro CC BY-SA 4.0
Gli impianti di frugale pino nero (Pinus nigra) del versante nord-orientale del monte, alla destra del sentiero, sono testimoni dello sforzo delle autorità cittadine e imperiali di preparare il suolo rendendolo adatto alla coltura di specie arboree necessarie all’industria cantieristica del prospero emporio. Il pino nero - che doveva essere solo una tappa nel processo di valorizzazione produttiva – è ormai diventato parte integrante del paesaggio del Carso triestino.
La cima del monte ospita cespugli quali il prugnolo (Prunus spinosa), il biancospino (Crategus monogyna), Rosa canina e diverse specie di rovi tra cui Rubus ulmifolius. Tra le erbacee troviamo paléo rupestre (Brachypodium rupestre), inula irta (Pentanema hirtum) e l’ astro spillo d'oro (Galatella linosyris).

Fiori e portamento di Galatella linosyris e Tanacetum corymbosum. Foto di Andrea Moro CC BY-SA 4.0
Il Danthonio-Scorzoneretum villosae, un raro prato-pascolo seminaturale su flysch - che caratterizzava in passato la cima del monte - è quasi completamente scomparso a causa dell’incespugliamento legato alla fine delle attività agro-pastorali.
I pendii del Monte Valerio ospitano - tra gli animali - il picchio verde (Picus viridis) e il picchio rosso maggiore (Picoides major) strettamente legati all’ambiente del bosco dove nidificano all’interno delle cavità degli alberi. In primavera può capitare di sentire il loro tambureggiare con lo scopo di delimitare il territorio. Presente tutto l’anno, lo sparviere (Accipitern nisus) caccia volando sugli alberi alla ricerca di piccoli uccelli e mammiferi. Tra i mammiferi è facile osservare il capriolo (Capreolus capreolus) - soprattutto nella boscaglia - e lo scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris), l’unico scoiattolo originario dell’Europa. Negli ultimi anni è stato registrato un sensibile aumento della popolazione di cinghiali (Sus scrofa).

In ordine: sparviere (foto di Meneer Zjeroen, CC BY-SA 4.0), picchio verde (foto di Clèment Bardot, CC BY-SA 4.0), capriolo (foto di Uoaei1, CC BY-SA 4.0), cinghiale (foto di Cellofilo, CC BY-SA 4.0).
Per un’approfondita scoperta di piante, muschi e licheni del Monte Valerio sono disponibili tre guide interattive:
tutte corredate di un originale apparato iconografico. Queste ed altre guide, prodotte nell’ambito del Progetto Dryades, sono consultabili sul sito web di Dryades.
Ultimo aggiornamento: 08-04-2025 - 13:20