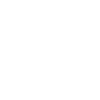- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
L'Orto Botanico dell'Università degli Studi di Trieste
L’Orto Botanico Universitario è situato sul colle di Monte Valerio, all’interno del campus universitario. L’accesso è libero e aperto a tutti. Gli ingressi pedonali sono tre: il cancello superiore con scalette su via L. Giorgieri (presso al “Castelletto”), il grande cancello inferiore su via Fleming (senza barriere architettoniche) e un cancello più piccolo, con gradino, sempre su via Fleming all’altezza della rampa per l’edificio H3. Chi arriva in auto può entrare dal Varco 10.

L'Orto Botanico Universitario è una istituzione che mantiene piante vive, documentate ed etichettate, aperta al pubblico con scopi di ricerca scientifica, educazione, esposizione, ricreazione e conservazione. Custodisce circa 400 specie cartellinate provenienti da Europa, Americhe, Africa, Asia e Australia, specie endemiche del Carso, del Friuli Venezia Giulia e dell’area mediterranea e una piccola sezione dedicata alle pteridofite. L'Orto Botanico vanta un esemplare monumentale di roverella (Quercus pubescens) bisecolare, unico albero rispettato durante i disboscamenti del periodo bellico.
Parte integrante dell'Orto Botanico, ma al di fuori del suo recinto e senza limiti d'orario, è il Sentiero Naturalistico del Monte Valerio, con diversi punti d'interesse valorizzati da cartelli esplicativi sulla flora e la fauna. L'ingresso del sentiero si trova di fronte al cancello superiore dell'Orto Botanico su via L. Giorgieri nei pressi del Castelletto.
L’Orto Botanico si sviluppa su una superficie di circa 2400 m2, a 120 metri d’altitudine su un terreno organizzato in terrazzamenti, esposto a sud ovest sul golfo di Trieste. Per la sua peculiare posizione geografica risente del clima submediterraneo della fascia costiera alto-adriatica con estati e inverni secchi e primavere e autunni piovosi. La piovosità è di circa 1100 mm/anno.
L’Orto botanico nacque nell’autunno del 1962 quando gli istituti biologici delle Facoltà di Scienze e Farmacia dell'Università di Trieste vennero insediati nella villa Sevastopulo, ex villa Valerio, al limite superiore del Campus Universitario. Nella villa avevano sede gli Istituti di Zoologia, Farmacologia, Fisiologia Generale e Chimica Biologica, mentre l'Istituto Botanico veniva insediato in un edificio agricolo adiacente. Venne assegnata al nuovo Orto tutta l'area circostante in buona parte tenuta a bosco seminaturale. Dalla primavera del 1963 iniziarono i lavori per la sistemazione dell'Orto: l’originaria struttura a tre gradoni sostenuti da muri in arenaria – tratto distintivo dei pendii arenaceo-marnosi che abbracciano il capoluogo giuliano – vennero rimodellati e solo in piccola parte conservati lungo l’attuale piccola serra fredda. Vennero quindi create piccole aiuole a roccera, tipiche dei giardini alpini, sostenute da spalliere di pietra carsica il cui colore grigio chiaro offre un piacevole contrasto con l’arenaria dei vecchi muri.
L’Orto Botanico Universitario custodiva in origine una collezione dedicata in prevalenza alla flora Carsica e regionale con alcuni esemplari a distribuzione illirica. Dopo una lunga fase di declino, la recente valorizzazione – avviata negli anni 2019-20 - punta a una maggior diversificazione per soddisfare le esigenze della didattica. L’Orto aspira a dotarsi di una collezione botanica con caratteristiche ecologiche, corologiche, fisiologiche, riproduttive diversificate al fine di fornire agli studenti un supporto al processo d’apprendimento continuando ad essere luogo della ricerca con spazi dedicati alle esigenze del Dipartimento.
L’Orto Botanico presenta diverse sezioni: all’ombra del secolare leccio sono custodite le pteridofite:emicriptofite rosulate come Asplenium scolopendrium, Pteris cretica, P. dentata, P. multifida e geofite rizomatose come Cyrtomium laetevirens, nei pressi della serra superiore c’è la sezione dedicata alle succulente con Aeonium arboreum, Agave americana, A. salmiana, Aloë sp., Carpobrotus edulis, Crassula ovata, nella parte pianeggiante piccoli specchi d’acqua accolgono le piante acquatiche: idrofite natanti come Lemna trisulca, idrofite radicanti come Alisma plantago-aquatica, geofite rizomatose come Limniris pseudacorus,Phragmites australis, Typha sp.

In ordine: Asplenium scolopendrium, Cyrtomium laetevirens, Pteris cretica. Foto di Andrea Moro CC BY-SA 4.0
Nella parte bassa dell’orto si sviluppa una vasta sezione dedicata alle fanerofite arboree e cespugliose con Abies alba, A. pinsapo, Berberis thunbergii, B. vulgaris, Ceratonia siliqua, Chamaerops humilis, Corylus avellana, C. maxima, Cryptomeria japonica, Euphorbia dendroides, Ginkgo biloba, Larix decidua, Lonicera tatarica, Malvaviscus arboreus, Medicago arborea, Myrtus communis, Nerium oleander, Osmanthus heterophyllus, Pinus nigra, P. nigra subsp. laricio, P. sylvestris, Phoenix canariensis, Prunus lusitanica, Punica granatum, Trachycarpus fortunei, Viburnum lantana, V. opulus, V. tinus, Yucca gloriosa, Y. rostrata, Ziziphus jujuba, etc.

In senso orario: fiore di Ceratonia siliqua, livrea autunnale di Ginkgo biloba, fiore di Diospyros kaki, frutti di Chamaerops humilis, legume di Medicago arborea. Foto di Andrea Moro CC BY-SA 4.0

In ordine: Lonicera tatarica, Malvaviscus arboreus, Magnolia x soulangeana. In fondo in alto: Cryptomeria japonica e Punica granatum. Foto di Andrea Moro CC BY-SA 4.0
Le piante termofile sono custodite nelle roccere a gradini della parte alta dell’Orto con specie provenienti dalle regioni a clima mediterraneo e tropicale dell’Africa, Americhe, Asia, Australia ed Europa. Citiamo, tra le diverse specie: le australiane Ozothamnus rosmarinifolius, (Asteraceae) (Nuovo Galles, Tasmania, Victoria), un piccolo arbusto sempreverde aromatico con piccole foglie verde scuro e vistose infiorescenze ad ombrella che ricordano quelle delle achillee (fioritura aprile-maggio). Westringia fruticosa (Lamiaceae) arbusto di piccola taglia con foglie lineari ricoperte sulla faccia inferiore da feltro bianco con fiori ascellari tubulari bianchi o blu pallido maculati (fioritura aprile - maggio).

In ordine: Eremophila nivea, Westringia fruticosa, Fabiana imbricata. Foto di Andrea Moro CC BY-SA 4.0
Attirano l’attenzione due specie africane: la vistosa Polygala myrtifolia (Polygalaceae) - un’alloctona casuale in Liguria, Sardegna, Sicilia e Puglia, molto apprezzata nei giardini per la prolungata fioritura (dalla primavera all’autunno) e Salvia aurea (Lamiaceae), della regione del Capo, riconoscibile dai fiori color marrone (fioritura aprile-maggio).

In senso orario, dall’alto: Centaurea cineraria, Anisodontea capensis, , Grevillea juniperina, Polygala myrtifolia, Ipomoea indica, Ozothamnus rosmarinifolius, Euphorbia characias, Myrtus communis. Foto di Andrea Moro CC BY-SA 4.0
Baccharis pilularis – l’arbusto del cojote - è un’Asteracea del chaparral della costa occidentale nord americana, una pianta pioniera che invade le praterie causando una drastica riduzione della biodiversità se non ostacolata da incendi o pascolamento.
Sono originarie dell’area mediterranea Teucrium subspinosum (Lamiaceae), endemica delle Baleari e della costa sud occidentale della Sardegna, un piccolo arbusto sempreverde (alto 20-30 cm) con foglie sessili lanceolate, infiorescenza a spiga e fiori bilabiati con calice lanoso e Ptilostemon gnaphaloides, una robusta Asteracea del Mediterraneo orientale (fioritura estiva). Centaurea cineraria (Asteraceae) - il fiordaliso delle scogliere - è una endemica delle coste liguri e tirreniche tassonomicamente complessa, con diverse sottospecie descritte e significative variazioni geografiche.
Le roccere accolgono anche una folta collezione di Cistacee: Cistus creticus (Mediterraneo orientale), C. ladanifer (Mediterraneo occidentale, Portogallo), C. monspeliensis (Mediterraneo settentrionale e Magreb), Cistus salviifolius (Mediterraneo), e le cultivar Cistus x heterophyllus, C. x incanus, C. x pulverulentus ‘Sunset’.
In ordine: Teucrium subspinosum, Euphorbia dendroides, Lavandula stoechas , Cistus ladanifer. Foto di Andrea Moro CC BY-SA 4.0
Nella parte bassa delle roccere, Euphorbia mellifera (Euphorbiaceae) è un arbusto originario dalle isole Canarie caratterizzato dal particolare profumo delle infiorescenze che ricorda il miele.
Quest’anno fiorirà per la prima volta Echium candicans, una Boraginacea originaria delle montagne di Madeira: un arbusto perenne cespuglioso con foglie lanceolate grigio-pelose e dense infiorescenze terminali a pannocchia con fiori bianchi o blu intenso (fioritura primavera – estate).
Galleria di Immagini Inaugurazione 2025
Ultimo aggiornamento: 10-06-2025 - 18:44