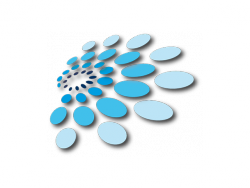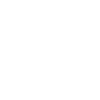L’attività scientifica, attuata sia singolarmente che tramite collaborazioni, riguarda: (1) l’applicazione di indici biotici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE; (2) lo studio dei macroinvertebrati bentonici in relazione al loro ruolo trofico, alla funzione nei processi decompositivi e nei trasferimenti energetici attraverso i livelli trofici negli ambienti dulciacquicoli; in tale contesto hanno particolare rilievo indagini relative alla densità energetica degli organismi ed indagini sui processi decompositivi della sostanza organica; (3) lo studio di specie ittiche dulciacquicole, sia per quanto riguarda la biologia delle singole specie che per quanto attiene alle strutture e alle dinamiche delle comunità da esse formate.
PROGETTI IN CORSO
1) Applicazione di indici biotici ai sensi della direttiva 2000/60/CE
La Direttiva 2000/60/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 152/2006, impone l’utilizzo di una serie di bioindicatori per la valutazione dello stato ecologico delle acque. Per gli ambienti lotici sono previste analisi a carico delle comunità macrozoobentoniche, ittiche, delle macrofite acquatiche e delle diatomee bentoniche. Nel D.M. 260/2010 vengono indicati gli indici biotici validi per le acque italiane che si basano sullo studio di detti bioindicatori. L’applicazione di tali indici porta a dei giudizi di qualità (elevato, buono, sufficiente, scarso e cattivo), dei quali il peggiore definisce lo stato ecologico dell’ambiente esaminato. Sulla base di tale valutazione, ambienti che raggiungeranno un giudizio solo sufficiente o scarso dovranno essere oggetto di operazioni di recupero.
In questo ambito, per quanto attiene ai lavori più recenti, nel periodo 2019-2021 si è svolta una collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, partner nell’ambito del Progetto GREVISLIN (GREen Vipava/Vipacco, and Isonzo/Soča INfrastructure), Interreg V-A Italia - Slovenia. Il progetto ha coinvolto diversi partners italiani e sloveni e ha avuto tra i suoi obiettivi i) migliorare la gestione dei bacini Isonzo (in particolare per il corridoio Isonzo/Vipacco) e Livenza sulla base di un piano di sviluppo transfrontaliero per le infrastrutture verdi a lungo termine; ii) rafforzare la cooperazione transfrontaliera nell'ambito del monitoraggio bilaterale dello stato delle acque.
In collaborazione con ETPI sono stati condotti campionamenti a carico della fauna ittica nel Fiume Isonzo e nel Fiume Vipacco, e sono stati effettuati confronti tra Italia e Slovenia circa le metodologie di monitoraggio dello stato di qualità delle acque e della biodiversità. Sono state inoltre analizzate le popolazioni di specie alloctone invasive, con particolare riferimento a Silurus glanis, di cui è stato indagato lo stato sanitario in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Val d’Aosta. In collaborazione con il laboratorio della Prof.ssa Monia Renzi, afferente al DSV e il Bioscience Research Center di Orbetello, è stato inoltre indagato il contenuto in microplastiche a carico di specie ittiche che, nella comunità osservata, rivestono diversi ruoli trofici. Queste ultime analisi fanno parte di uno studio più vasto ed articolato che si prefigge lo scopo di indagare gli effetti delle microplastiche nelle reti trofiche delle comunità animali che popolano gli ambienti dulciacquicoli.

Vista del lago di Doberdò durante attività di campionamento (Foto: Bertoli, 2021)
2) Studio delle comunità a macroinvertebrati bentonici e della decomposizione della sostanza organica in ambienti dulciacquicoli
I macroinvertebrati bentonici rivestono un ruolo fondamentale negli ambienti dulciacquicoli: sono una importante risorsa trofica per molte specie di uccelli e pesci, coprono tutti i ruoli trofici dei consumatori e vengono utilizzati come bioindicatori, come richiesto dalle Direttive europee. Inoltre, essi hanno un ruolo chiave nel processamento del detrito e rivestono un ruolo fondamentale nella decomposizione della sostanza organica, processo di fondamentale importanza nelle dinamiche degli ambienti acquatici. In questo contesto sono stati condotti lavori volti ad investigare i tassi di decomposizione della sostanza organica vegetale mediante trappole trofiche, le quali permettono sia l’analisi dei meccanismi decompositivi che delle comunità macrozoobentoniche coinvolte. Gli studi sono stati e vengono effettuati su base stagionale in diversi ambienti (area umida dell’Isola della Cona, foce del Fiume Isonzo, Fiume Vipacco e Lago di Doberdò), con l’obiettivo di indagare i tassi di decomposizione e le relazioni con stagionalità, comunità macrozoobentoniche e le caratteristiche abiotiche degli ambienti indagati.

Capsula cefalica di un dittero chironomide (genere Paratanytarsus) rinvenuto nell'ambito del progetto sui laghi alpini (Foto: Bertoli 2020)
Per quanto attiene ai progetti più recenti, in seno ad un progetto di monitoraggio svolto in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, sono stati condotti degli studi presso il lago carsico di Doberdò, i cui risultati hanno permesso di evidenziare gli effetti delle variazioni del livello idrico sulle dinamiche del sistema e le risposte della comunità macrozoobentonica. È stato inoltre possibile evidenziare gli effetti che le variazioni di livello determinano sulla decomposizione della sostanza organica vegetale, anche in relazione ai cambiamenti climatici attualmente in corso.
Gli studi condotti in ambiente fluviale hanno visto l’analisi delle comunità macrozoobentoniche e dei tassi decompositivi nel Fiume Vipacco. In collaborazione con il laboratorio della Prof.ssa Monia Renzi, afferente al DSV e il Bioscience Research Center di Orbetello, sono state condotte analisi circa l’impatto delle microplastiche sulla comunità macrozoobentonica, in relazione ai ruoli trofici rivestiti da questi organismi all’interno degli ambienti dulciacquicoli. Gli studi si propongono inoltre di indagare gli effetti degli impatti da microplastiche sui meccanismi decompositivi della sostanza organica vegetale. In particolare, gli studi si focalizzano sul rapporto tra microplastiche, comunità macrozoobentonica e tassi di decomposizione in relazione a variazioni di portata e parametri chimico-fisici.
3) Analisi ecologiche in ambienti lentici alpini e subalpini
I laghi alpini sono ritenuti spesso ambienti incontaminati a causa della loro posizione. Nonostante ciò, fin dai primi anni ’80, sono state evidenziati gli effetti negativi che le attività antropiche hanno su questi ambienti, particolarmente sensibili agli impatti globali e considerati indicatori a “risposta rapida” per quanto concerne i cambiamenti climatici e la deposizione di inquinanti atmosferici. Queste minacce influenzano le caratteristiche chimiche e biologiche delle acque lacustri, in particolare la distribuzione delle specie, i livelli di ossigenazione e il ciclo dei nutrienti.
Gli obiettivi del progetto sono di implementare le conoscenze circa i laghi alpini nell’Italia Settentrionale e fornire informazioni utili alla preparazione di appropriati piani di gestione per la conservazione delle aree di studio e delle specie presenti, grazie ad indagini riguardanti la morfologia lacustre, i substrati, i parametri chimico-fisici delle acque, alle principali comunità animali e vegetali. In questo contesto è di particolare interesse lo studio dello stato di conservazione degli anfibi elencati nella Direttiva Habitat 92/43/CEE, quali Bombina variegata e Rana temporaria.
I piani di campionamento stagionali includono la caratterizzazione chimico-fisica dei corpi idrici, l’analisi delle comunità macrozoobentoniche, delle comunità ittiche e delle macrofite acquatiche. Inoltre, vengono investigate le concentrazioni dei metalli pesanti e degli inquinanti organici a differenti livelli delle reti trofiche (sia per i pesci che per i macroinvertebrati bentonici), in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Val d’Aosta.
Le analisi implicano l’uso di gas-cromatografia, cromatografia liquida e spettrometria di massa. Infine, viene investigato il potenziale impatto delle specie ittiche presenti sulle popolazioni di anfibi precedentemente citate, con particolare attenzione alla possibile presenza di specie alloctone. Il progetto prevede anche lo studio delle paleocomunità lacustri (Ditteri Chironomidi, Ostracodi, Diatomee), allo scopo di indagare i cambiamenti occorsi nel tempo in relazione a fenomeni globali e all’introduzione di specie aliene.

Esemplare di trota marmorata (Salmo marmoratus) durante il rilevamento dei dati biometrici (Foto: Franz, 2017)
4) Analisi delle comunità ittiche dulciacquicole e indagini biologiche/ecologiche su specie ittiche d’interesse
Da molti anni, vengono condotti progetti finanziati dall’Ente Tutela Patrimonio Ittico ETPI (ex Ente Tutela Pesca, ETP) con lo scopo di studiare la distribuzione delle specie costituenti le comunità ittiche dulciacquicole nel Friuli Venezia Giulia. I monitoraggi sono condotti in relazione alle continue trasformazioni delle comunità ittiche, causate sia da fattori naturali che antropici. Tra le fonti di impatto legate alle attività dell’uomo vi sono le derivazioni a scopo idroelettrico, le immissioni per fini alieutici, le immissioni di specie aliene e gli interventi di riqualificazione fluviale. È dunque importante monitorare lo status delle comunità ittiche in maniera costante nel tempo, con l’obiettivo di ottenere informazioni al fine della preparazione di adeguati piani di gestione, basandosi su dataset più recenti possibile.
Studi specifici sono condotti su specie ittiche ritenute d’interesse, al fine di investigare alcuni aspetti riguardanti la biologia e di definire le corrette aree di distribuzione. Recentemente sono stati effettuati dei lavori riguardanti gli aspetti riproduttivi di Salmo marmoratus, la tassonomia del genere Esox e la distribuzione di specie invasive quali Silurus glanis. Inoltre, sono stati condotti studi riguardanti la biologia, la distribuzione e la riproduzione di Barbus balcanicus e di Gobio benacensis nei piccoli tributari del bacino dell’Isonzo. Altri lavori hanno riguardato Aphanius fasciatus, Knipowitschia panizzae (elencati nella Direttiva 92/43/CEE) e Pomatoschistus marmoratus negli ambienti salmastri della Riserva Naturale Regionale della Foce dell’Isonzo.
Attualmente è attivo un progetto che prevede l’eradicazione della trota fario (Salmo trutta) di ceppo atlantico dal Torrente Rosandra, all’interno della Riserva Naturale della Val Rosandra-Dolina Glinščice. Il progetto viene condotto in collaborazione con l’organo gestore della Riserva (Comune di S. Dorligo) e con ETPI. Sempre in collaborazione con ETPI è inoltre in corso un progetto che prevede l’eradicazione del naso (Chondrostoma nasus) nel Rio Chiarò e uno studio che prevede indagini ecologiche a carico delle specie ittiche (con particolare riferimento a quelle di interesse comunitario) per la loro gestione nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Operazioni di campionamento tramite elettropesca sul Torrente Rosandra (Foto: Di Luca, 2020)
È attualmente in corso un lavoro che vede la collaborazione tra il DSV, il Politecnico di Torino e l’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali allo scopo di raccogliere informazioni circa distribuzione e preferenze di habitat per specie ittiche autoctone. Le informazioni raccolte verranno poi utilizzate al fine produrre modelli utili a calibrare e validare la metodologia MesoHABSIM (MesoHABitat SIMulation model, Manuali e Linee Guida ISPRA 154/2017) nelle aree di pianura e risorgiva localizzate all’interno del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali. I risultati saranno utili per l’attuazione del Programma delle Misure e per la verifica del deflusso ecologico.
Infine, la dott.ssa Pizzul sta collaborando all’aggiornamento della Red List delle specie ittiche italiane d’acqua dolce, redatta da IUCN.